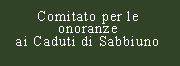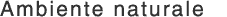|
|
| |
|
|
|
| |
LE PIANTE
Affacciandosi sul calanco si può notare quanto l’ambiente
sia inospitale per la vegetazione. La copertura arborea manca quasi
del tutto e qualche esemplare isolato di Cerro, Roverella, Olmo
e Acero campestre compare solo dove la pendenza è minore
e sui versanti esposti a nord. Lungo le pareti più scoscese
e soggette a forte erosione, soprattutto se esposte a sud, scarseggiano
anche gli arbusti: solo i cespuglieti a Ginestra, grazie al poderoso
e tenace apparato radicale di questa specie, resistono al continuo
sfaldamento della superficie; dove la pendenza è minore si
aggiungono Rosa selvatica, Biancospino, Rovo, Asparago selvatico
e, a tratti, il sempreverde Ligustro. Le pendici più fresche
rosseggiano in autunno e inverno per la presenza del Sanguinello.
Un po’ dovunque il calanco è punteggiato da una conifera
molto rustica, il Ginepro, un alberello sempreverde che si adatta
a tutti i suoli ed è importantissimo per la sua capacità
di ricoprire quelli deforestati, preparando il suolo al ritorno
del bosco. Le piante erbacee sono ridotte a poche specie adattate
a sopravvivere in queste condizioni estreme: dominano Agropyron
litorale, una graminacea tipica di suoli molto aridi come le dune
costiere, e Aster linosyris, una composita dalle foglie lineari,
accompagnate dai cespugli di un’altra composita, i Ceppittoni.
Il fondo delle vallecole, dove il suolo è intriso d’acqua,
ospita qualche cespuglio di Salice e il Farfaro, una piccola composita
che fiorisce in febbraio colorando per prima i calanchi di bellissime
macchie gialle.
|
|
|
| |

|
Durante gli anni ’70 alla base del calanco è stata
realizzata un’opera di regimazione idraulica costituita da
una soglia con un canale emissario in cemento, a monte della quale
si è formato un laghetto artificiale ormai interrato, che
è circondato da una vegetazione igrofila a Canne di palude
e Mazze sorde. L’intervento è stato un tentativo per
recuperare il calanco dal basso, rallentando l’erosione e
dalla colmata la vegetazione pioniera sta cominciando a risalire
lentamente il pendio.
Nelle aree non calanchive del parco, che prima dell’acquisizione
pubblica erano utilizzate soprattutto a prato e seminativo semplice,
a partire dalla metà degli anni ’80 sono stati effettuati
interventi di rimboschimento con alberi e arbusti tipici della
vegetazione collinare. I prati e le cavedagne si ricoprono in
primavera delle fioriture di Pratolina, Tarassaco, Salvia dei
prati e Muscari.
Le scarpate a monte e a valle della via di Sabbiuno, non più
sfalciate, si sono anch’esse spontaneamente rivestite di
arbusti tipici della vegetazione collinare e sono state poi arricchite
con Alberi di Giuda e Ornielli. È questa l’unica area
fruibile dai visitatori: soprattutto quando il terreno è
umido, è infatti sconsigliabile avventurarsi per gli stretti
sentieri delle creste calanchive.
|
|
|
LA POIANA E ILGHEPPIO
La poiana (Buteo buteo) e il gheppio (Falco tinnunculus)
sono tra i più comuni uccelli da preda della collina e
frequentano regolarmente la zona del parco. La poiana è
spesso osservabile mentre volteggia maestosamente utilizzando
le correnti d’aria calda che salgono verso l’alto. In
questo modo questo grande uccello dal piumaggio brunastro, di
intensità variabile da individuo a individuo, si mantiene
a lungo in volo senza sforzo alla ricerca di piccoli mammiferi,
rettili, uccelli e animali morti. Non cattura mai le prede in
volo ma a terra, dopo averle inseguite volando a bassa quota.
A volte attende, però, la preda all’agguato, posato
su un palo, un ramo o una sporgenza rocciosa. In estate cattura
anche grandi insetti nei prati, camminando e saltellando sul terreno
come un pollo. Il gheppio ha una taglia decisamente inferiore,
corpo snello e ali lunghe e appuntite. Caccia prevalentemente
piccoli roditori, lucertole e grossi insetti e più raramente
anche piccoli uccelli. Spesso vola a bassa quota cercando di sorprendere
allo scoperto la preda, ma la tecnica di caccia più frequente
è quella detta dello “spirito santo”, che consiste
nell’esplorare il terreno mantenendosi fermo nell’aria
a circa dieci metri d’altezza mediante rapidi battiti d’ali.
|
 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|