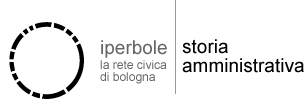Antonio Zannoni Professore di Architettura
Maria Beatrice Bettazzi, Antonio Zannoni e l’insegnamento dell’architettura agli ingegneri.
La notorietà di Antonio Zannoni (1833-1910) fuori dagli ambiti disciplinari e bolognesi, si deve soprattutto all’opera di archeologo. Come è noto, si imbatté quasi casualmente in una necropoli etrusca di grande importanza per la storia delle origini della città, mentre lavorava agli ampliamenti e abbellimenti del Cimitero della Certosa.
Qui vorrei invece ricostruire brevemente la sua fisionomia di docente di architettura agli ingegneri, attraverso il pluriennale operato presso la cattedra di Architettura Tecnica, al terzo e ultimo anno di corso. In carico dal 1882-83, quando sostituisce Fortunato Lodi, tiene l’insegnamento fino alla morte, nel 1910. Dallo spoglio degli Annuari apprendiamo che, come sempre avveniva, inizia la carriera come incaricato e solo con l’anno accademico 1895-96 Zannoni è citato come ‘straordinario’, proprio mentre Attilio Muggia, che era stato allievo dell’ingegnere-archeologo e sarà destinato a succederli, viene incaricato di Architettura Tecnica al primo anno, in qualità di libero docente. Nel 1899 Zannoni è ordinario di Architettura Tecnica ed altresì già da tempo responsabile del relativo Gabinetto, insieme a quello diretto da Muggia per Costruzioni civili in crescita di anno in anno con l’acquisizione di volumi e materiali didattici, in parte ancora oggi rintracciabili nei moderni assetti delle attuali strutture bibliotecarie.
Zannoni è il tipico ingegnere totale, esperto di tutto e in grado di formulare progetti su una gamma sterminata di temi, come sta a testimoniare una sua bibliografia piuttosto completa pubblicata, nel 1908-09, ad un anno dalla morte (1). I titoli testimoniano competenze su problemi di viabilità stradale e ferroviaria, di irregimentazione di acque e progettazione di acquedotti, su questioni relative a progetti architettonici di nuova costruzione e restauri di edifici storici, ma anche studi di tipologie particolari come quelle ospedaliere, oltre alla grossa parte dedicata all’archeologia. Questa complessità è favorita da un’attività professionale densissima di incarichi pubblici e privati.
Professionalmente nasce nel pool di giovani ingegneri che supportano l’attività di Coriolano Monti nell’immediato periodo seguito all’Unità d’Italia, quando Bologna si dota delle prime infrastrutture e muta il suo paesaggio urbano adattandosi ai tempi moderni. Zannoni è figura centrale nell’ideazione e realizzazione di via Indipendenza, asse cardine che collega la stazione ferroviaria col centro cittadino e avrà un ruolo fondamentale nella riattivazione dell’antico acquedotto romano che garantirà per la prima volta una rete potabile alla città. Al fianco dei professionisti più maturi, Monti e Cipolla, anche Zannoni lascia testimonianze architettoniche nel nuovo salotto buono bolognese: la piazza Cavour e le vie limitrofe, ingrandite e connesse con la viabilità principale del centro storico, diventano un campionario dell’architettura colta e borghese di una città di media grandezza e forse un po’ provinciale. Domina il classicismo nelle gamme del neorinascimento, toscano nel Palazzo Silvani di Cipolla o cinquecentesco nel Palazzo Guidotti di Monti. Zannoni partecipa con il riadattamento di Palazzo Legnani Pizzardi e con le Palazzine Bottrigari che presentano un’inconsueta loggia scandita da un ordine gigante di colonne corinzie. Caratteristiche di Bologna, un po’ in tutti i tempi a dire il vero, sono, da un lato, la medietas di un’architettura che mantiene un tono costante, che non presenta acuti, assoli o forzature (per il periodo che ci riguarda, il tardo Ottocento, forse solo l’edificio della Cassa di Risparmio di Mengoni); dall’altro, il paradosso di un centro storico omogeneo che trova in questa qualità senz’altro un punto a favore (divulgato e imitato in tutto il mondo a partire dagli anni Sessanta del Novecento). Ma questa omogeneità è anche il suo limite perché la percezione e l’immagine di una città così connotata livella e stempera ogni anelito individuale portando in secondo piano, dietro al cordone pressoché ininterrotto dei portici, l’opera più o meno originale del progettista di turno. Per guardare le facciate degli edifici, la città va percorsa in strada, col naso all’insù, non sotto ad un portico, con lo sguardo attratto dalla vita che brulica al riparo di sole e intemperie.
Zannoni pare cercare una via propria, per quanto poco condivisa dai contemporanei non teneri nei giudizi sulle sue architetture. Dopo le palazzine Bottrigari, un altro importante edificio, il Palazzo Cavazza sulla storica via Galliera, prova a staccarsi dal contesto esibendo una ornamentazione ricca, una variante di maniera al primo rinascimento bolognese che gli sta a fianco, tutto laterizi (2). Potremmo definirla una concordia discors nel senso che ci pare che vi sia una ricerca da parte del progettista di autonomia formale, ma nel riferimento costante ad una base storica data, tramite l’allineamento delle cornici o la ripresa di modelli centinati di finestre al piano nobile.
Sono in effetti questi gli insegnamenti che Zannoni impartisce, quando si trova a succedere a Fortunato Lodi sulla cattedra di Architettura tecnica alla Scuola di Applicazione per Ingegneri di Bologna, nel 1891. L’evento è fissato dalla pubblicazione della prolusione al corso (3) in cui il professore ripassa coi suoi studenti, inaspettatamente ritrovati dopo il biennio presso la facoltà di Scienze matematiche, il tragitto insieme compiuto. Tragitto fatto non solo di cognizioni teoriche ma anche di esercitazioni grafiche, «secondo il principio imprescindibile, che la rappresentazione deve scaturire dalla funzione: e la mano obbedisca all’intelletto» (4). Ma per diventare architetto, sostiene Zannoni, è necessario conoscere l’architettura dei tempi passati, «conoscere come la storia siasi svolta geograficamente, politicamente, socialmente, secondo le abitudini dei diversi popoli» (5) e con uno stile letterariamente alto passa in rassegna brevemente tutti i grandi momenti della storia dell’architettura, dall’antichità fino alla Rinascenza e ai giorni a lui contemporanei. Questi sono connotati da un «divagare dell’architettura e tanto divagare si riassume in queste schiere: imitatori, ecclettici, innovatori ... sorvolano alti sui giardini di tutti i tempi, ed intendendo succhiare al calice di ogni fiore architettonico, pretendono di offrire il miele dell’ecclettismo: qua e là qualche ardito pioniere ha piantato il vessillo sul bastione della novità...» (6). Il senso dello studio sarà ricercare il carattere dello stile di ogni tempo, in modo analitico per la sua conoscenza e in modo sintetico per consentire «la conservazione e il compimento delle opere architettoniche» ed in vista del progresso dell’architettura contemporanea.
In conclusione, dice Zannoni: «io osservo che noi non possiamo riguardare le opere dell’Antichità, che sotto l’aspetto di una bellezza relativa, riferendole cioè al loro tempo; e sotto l’aspetto di una bellezza assoluta, la quale è rimasta attraverso ai secoli, e rimarrà sempre ... perché certi sentimenti del vero si perpetuano, e rimane più che mai inconcusso l’assioma ‘siate veri e sarete eterni’»(7). Più avanti specificherà in cosa di declina questo ‘vero’ a cui è necessario attenersi: «la semplicità, l’unità, l’armonia delle proporzioni, la grazia, l’eleganza, il sentimento, la magnificenza, il sublime! Ed è questa la sintesi che deve emanare dal nostro studio, ed è questa l’unica sintesi che possa giovare all’architettura nostra, la quale non può, né deve essere, no, il plagio servile delle architetture del passato, ma tutta del suo tempo, e pel suo tempo» (8).
L’intero contenuto di questo primo corso, pubblicato per i tipi di un editore locale, culmina, in modo sintomatico, in un accorato appello, tipico di un intellettuale di tardo Ottocento: «Giovani egregi, in alto adunque e mente e cuore, fissi in quel lume veramente inestinguibile, eterno che dicesi ‘Progresso’»(9).
Nella sovrabbondanza e ricchezza dei testi zannoniani (10) isoliamo qui solo alcuni nodi concettuali per ancorare il pensiero del nostro al filo di una riflessione più ampia. Anzitutto il tentativo di fissare gli elementi di un’estetica dell’Architettura Tecnica – da lui definiti ‘Codice’- che ha un suo perno fondamentale nella ‘verità’, cioè l’esatta corrispondenza della forma con l’idea. Essa si persegue trattando in modo corretto , ‘razionalmente’, due variabili: uso e carattere, quest’ultimo termine spesso preferito a stile. In effetti anche Zannoni si scaglia contro il male del suo tempo, il ‘panstilismo’ o eclettismo per uscire dal quale, fra le soluzioni proposte, vi è anche quella, interessante, dell’applicazione più attenta e accurata dei dettami della nuova ingegneria sanitaria. Su questo tema è ferratissimo e dedica molte pagine a delineare i principi cardine di quella che può definirsi una proto disciplina urbanistica, nella consapevolezza che «purtroppo fin qui l’Italia è andata più che altro dietro alla decorazione interna ed esterna degli edifici di quello che abbia cercato l’igiene pubblica e domestica. All’Italia si è dato appena oggi un codice sanitario, all’Italia mancarono disgraziatamente, sino a pochi anni fa, studi di ingegneria sanitaria, ed è appena da ieri che l’Ingegneria sanitaria entrava nella convenzione pubblica. Progredirà senza dubbio, od almeno auguriamocelo» (11).
Quale è il lascito di Zannoni? Oltre alla continua implementazione dei materiali didattici, un insegnamento, almeno in teoria, molto aggiornato e consapevole di quanto si produceva all’estero, soprattutto in Francia, come le note e gli incisi dei suoi testi dimostrano; una abbondante riflessione tipologica riguardo ai nuovi edifici per la città moderna, ospedali e mercati prima di tutto, ma in genere un’idea ampia di spazio urbano che non è solo la sequenza teatrale di quinte architettoniche, ma un vero e proprio organismo pulsante fatto di reti infrastrutturali, idriche, stradali, ferroviarie, soggetto a piani razionali di intervento e di sviluppo.
(1) Si veda Regia Scuola di Applicazione per gli ingegneri in Bologna, Commentari dell’organizzazione e di un trentennio di vita della scuola ed annuario per l’anno scolastico 1908-1909, Bologna, Stabilimento poligrafico emiliano, 1909, pp. 445 e ss.
(2) Per quanto un disegno inedito della Collezione Zannoni all’Archiginnasio riveli un primo progetto di omogeneizzazione fra i due edifici contigui
(3) Architettura tecnica. Prolusione dell’Ingegnere architetto Antonio Zannoni al 1° Corso 1891-92 della R. Scuola di Applicazione degli Ingegneri in Bologna, Bologna, Società Tipografica Azzoguidi, 1892
(4) Ibidem, p. 5
(5) Ibidem, p. 6.
(6) Ibidem, p. 12
(7) Ibidem, pp. 14 e s.
(8) Ibidem.
(9) Architettura Tecnica. Primo corso, Stili Architettonici, lezioni del prof. A. ing. Zannoni, anno scolastico 1891-92, Bologna, Tipografia Litografia, A. Pongetti, 1892, p. 61.
(10) Ricordiamo, oltre a quelli già citati qui, Dell’uso degli ordini architettonici. Nota critica dell’ingegnere architetto Antonio Zannoni, Professore di Architettura all’Università ed alla regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Bologna, Firenze, Tipografia Minori Corrigendi, 1896 e Architettura Tecnica, Lezioni dell’Ingegnere Antonio Zannoni, Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, Bologna, 1904-1905.
(11) Architettura Tecnica, 1904-05, cit, p. 75.